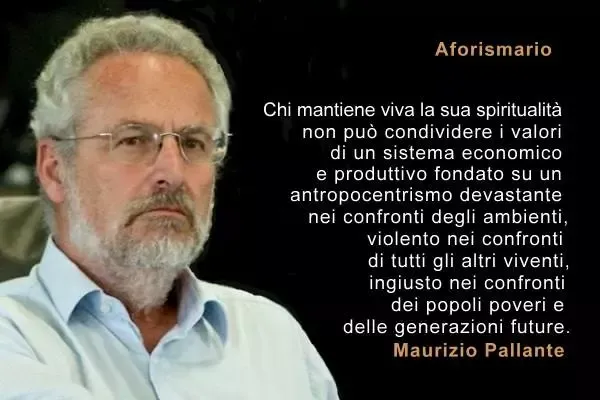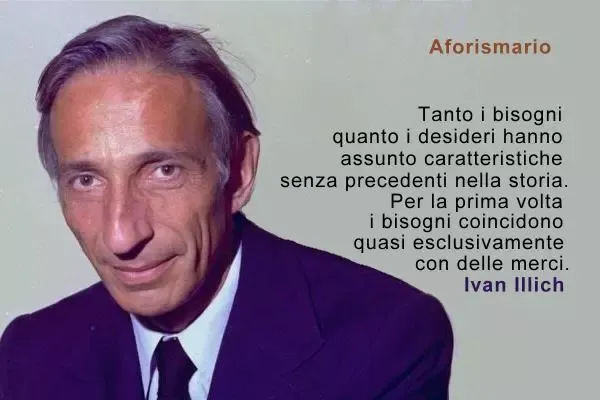Selezione di frasi e citazioni di Carlo Petrini (Bra, 1949), gastronomo, sociologo, saggista e attivista italiano, fondatore nel 1986 dell'associazione Slow Food, che si pone come obiettivo la promozione di una gastronomia sana e piacevole, in contrapposizione al dilagare del fast food e del cibo spazzatura. Fin dal 2004, ogni due anni, Slow Food organizza un grande meeting internazionale di comunità del cibo, chiamato Terra Madre, che è diventato oggi una potente rete mondiale del cibo sostenibile:
"Era tempo di riconoscere che il settore enogastronomico era uno dei grandi pilastri del nostro essere italiani, del nostro modo di lavorare e di vivere, qualcosa di importante su cui porre le basi per un futuro migliore. Bisognava iniziare a prendere piena coscienza del suo valore, economico e culturale; bisognava smetterla di affrontarlo come un gioco simpatico, un hobby da edonisti e niente più".
 |
| Il cibo resta e resterà la migliore forma di diplomazia della pace tra i popoli che abbiamo oggi a disposizione, nonché la miglior fonte di piacere e felicità. (Carlo Petrini) |
Buono, Pulito e Giusto
Principi di una nuova gastronomia © Einaudi, 2005 - Selezione Aforismario
Connessa al processo di industrializzazione, in poco più di un secolo si è progressivamente instaurata una sorta di dittatura tecnocratica in cui il profitto prevale sulla politica, l’economia sulla cultura e la quantità è il principale, se non l’unico, metro di giudizio per le attività umane.
Il «vascello spaziale Terra» sta andando verso il baratro. Non è più un segreto o una monotona – per quanto giusta e urgente – rivendicazione degli ambientalisti più radicali: consumiamo più di quello che il pianeta può offrire senza alterare il proprio equilibrio.
Il cibo è il principale fattore di definizione dell’identità umana, poiché ciò che mangiamo è sempre un prodotto culturale.
Terra Madre
Come non farci mangiare dal cibo
© Giunti e Slow Food Editore, 2009 - Selezione Aforismario
Il consumismo è un'ideologia che depreda le risorse, spreca e alla fine non soddisfa veramente i bisogni. Nel mondo del cibo industriale-globale quest'ideologia ha raggiunto il suo apice: siamo dei prodotti di consumo e pertanto possiamo essere depredati addirittura della nostra anima, sprecati come un prodotto seriale, usati senza mai raggiungere uno stato di reale benessere. Il cibo ci mangia.
Il cibo è il nostro legame più profondo con il mondo esterno, con la Natura: mangiare ci rende parte di un sistema complesso che gli antichi descrivevano come il “respiro della Terra”.
“Mangiare” è un atto che ci dà piacere ma che sempre più frequentemente genera ansia, di cui ci piace parlare anche se non ne sappiamo abbastanza.
Il mangiare, per le più svariate ragioni, è sempre più al centro dei nostri pensieri e dei nostri discorsi. Ma più che piacere e gioia − come dovrebbe − genera incertezza, inquietudine, ansie, paure: l'atto tra i più indispensabili per la nostra sopravvivenza diventa un problema.
Mangiare oggi genera incertezza, ansie e paure perché pretendendo di tenere la Natura fuori dalla sfera umana, abbiamo finito con l'estromettere anche il cibo, dimenticandoci il significato di una azione che compiamo almeno tre volte al giorno tutti i giorni
Il cibo è politica, il rispetto della diversità è politica, i modi in cui ci si prende cura della natura è politica.
Il cibo si è trasformato da elemento vitale, identitario, da miracolo della natura che si trasforma in cultura, in un prodotto come gli altri che risponde a tutte le leggi del consumismo: da quelle di mercato fino a quella dello spreco.
Il cibo oggi è prodotto soprattutto per essere venduto, non per essere mangiato. Ridurre il nostro rapporto con ciò che mangiamo quasi esclusivamente a una serie di operazioni di mercato è sia la causa sia l'effetto di un sistema che ha tolto valore al cibo e ha tolto significato alle nostre vite.
Il mangiare, nel mondo di oggi, è attraversato da continui paradossi. Fame nel mondo e malnutrizione, insieme alle pandemie planetarie dell'obesità e del diabete, sono facce della stessa medaglia.
La politica ha estromesso i contadini dal processo democratico: nell'Occidente ricco perché il loro numero è quasi irrilevante; nel Sud del mondo perché li considera masse da sfruttare al momento del voto, ma sicuramente non meritevoli di raggiungere un livello di qualità della vita per lo meno dignitoso.
Il deserto si trova proprio nei templi del consumismo, in quelle megalopoli che s'ingrossano di povera gente che ha perso ogni speranza.
Dei tre valori della Rivoluzione Francese, libertà, uguaglianza e fraternità, sembra siano sopravvissuti soltanto i primi due, riconosciuti da tanti, anche se invocati spesso a sproposito. Ma la fratellanza, la fraternità, sembra essere sparita dall'ordine dei valori delle società occidentali.
È necessario abbandonare ogni visione bucolica e anacronistica del contadino, del produttore di cibo: bisogna invece riconferirgli tutta la sua dignità e toglierlo dalla nicchia di arretratezza e marginalità economica in cui è stato relegato.
Le attuali crisi e il momento storico che stiamo vivendo rendono evidente la necessità di trasformazioni profonde. Siamo dentro un'era di passaggio, nella quale dovranno cambiare sistemi di gestione della politica, della cultura e dell'economia, in cui servono nuovi paradigmi.
Se voglio mangiare bene sono un elitario, se rispetto la tradizione sono ancorato al passato, se seguo regole di buona ecologia sono noioso, se guardo all'importanza del mondo rurale sono in cerca di bucoliche sensazioni… È difficile parlare dell'importanza del cibo e dell'agricoltura, del valore di saper produrre e consumare alimenti in maniera sostenibile, senza incappare in simili critiche, più che altro figlie di luoghi comuni
Il piacere alimentare, come tutti i piaceri, è fisiologico e dunque in sé non dovrebbe avere nulla di male. Invece è additato come peccaminoso, impopolare, genera pruriti moralistici e rimproveri dei “compagni”, moniti salutisti o accuse di superficialità.
Il piacere è un dono della natura; contrapporlo all'impegno e all'etica non aiuta a comprenderne la bellezza.
Il piacere alimentare è quello potenzialmente più immediato e alla portata di tutti: mangiare, e con piacere, può essere un atto politico dirompente. Il piacere non è elitario, è un diritto, e va tutelato promuovendolo, conoscendolo, rendendolo davvero alla portata di tutti.
Nel mondo così detto “sviluppato”, la società dei consumi permea così a fondo le nostre vite che non possiamo dirci estranei da colpe.
Tutti noi siamo in qualche modo complici delle crisi che hanno colpito il Pianeta. I nostri comportamenti, volenti o nolenti, non sono mai del tutto virtuosi; in molti casi infatti non possiamo restare totalmente esterni al sistema e siamo costretti a supportarlo, oltre che sopportarlo.
Il cibo resta e resterà la migliore forma di diplomazia della pace tra i popoli che abbiamo oggi a disposizione, nonché la miglior fonte di piacere e felicità.
Bisogna lasciarsi alle spalle il pregiudizio che il cibo buono sia una cosa elitaria e soprattutto seguire due regole elementari: ricercare la qualità fuori dal sistema consumistico e riscoprire le buone pratiche domestiche e gastronomiche.
Riappropriamoci dei sensi per capire cosa è buono e conoscere meglio quello che ci circonda, riappropriamoci della realtà.
Perdendo un rapporto sano con il cibo abbiamo fatto sì che la Terra, da madre buona e premurosa, si trasformasse in una matrigna cattiva; e va riconosciuto che ne ha avuti tutti i motivi.
Cibo e libertà
Slow Food: storie di gastronomia per la liberazione
© Giunti e Slow Food Editore, 2013 - Selezione Aforismario
Un gastronomo che non è un ambientalista è certamente uno stupido, ma un ambientalista che non è anche gastronomo è triste!
Un gastronomo che consuma i prodotti della terra non può restare insensibile di fronte alle tematiche ambientali.
La nostra idea di gastronomia non può prescindere dal diritto universale di nutrirsi a sufficienza e secondo la propria cultura: è un problema mondiale la cui mancata soluzione rappresenta uno scandalo assoluto, di fronte al quale un vero gastronomo non può restare indifferente.
...quella follia collettiva che è l’esplosione massmediatica del tema alimentare, soprattutto nei programmi televisivi che a qualsiasi ora e su qualsiasi canale traboccano di cibo, in una forma che non esito a definire pornografica.
Un importante strumento di liberazione per certe società e territori sta nella rivalutazione o riscoperta, in chiave strettamente gastronomica, della biodiversità e delle tradizioni culinarie locali, anche nei luoghi più insospettabili, e con formule che non hanno nulla da invidiare alla migliore ristorazione mondiale.
Perché oggi nessuno inorridisce di fronte allo scempio rappresentato dai dati su fame e malnutrizione? Che cosa ci vuole perché si formi un movimento internazionale e popolare che combatta questa piaga, in fin dei conti da quasi tutti tollerata su questo Pianeta, proprio come un tempo si tollerava la schiavitù?
Il diritto al cibo oggi è sancito dalle carte degli organismi internazionali, ma quasi un miliardo di persone ne soffre ancora la mancanza. È giunto il momento di dire basta, di unire le forze, e lavorare per un altro trionfo storico in nome dei diritti universali. E i gastronomi devono essere in prima linea, se di cibo si parla. Dobbiamo liberarci da fame e malnutrizione.
Un'idea di felicità
Conversazione tra Carlo Petrini e Luis Sepúlveda
© Guanda e Slow Food Editore, 2014 - Selezione Aforismario
Purtroppo, la rivendicazione, decisa, del diritto al piacere è stata sempre per noi croce e delizia. Croce perché ci ha subito posto nella categoria dei privilegiati, quelli che grazie ai soldi possono mangiare meglio rispetto agli altri. E delizia perché io penso che il diritto al piacere sia un diritto universale di tutta l’umanità, non solo della parte ricca.
Io sono agnostico, il piacere preferirei averlo su questa terra, non in quell’altro mondo.
Il diritto al piacere deve essere garantito a tutti e per questo va anche misurato con la nostra capacità di non esagerare.
Il piacere in campo alimentare non è crapula, non è eccesso, non è pensare a se stessi e non condividere.
Noi occidentali, intanto, siccome finora in Africa abbiamo soltanto saputo rubare attraverso forme di colonialismo o neocolonialismo terribili, è tempo che iniziamo a restituire qualcosa.
Se il cibo deve tornare al centro delle nostre vite perché è piacere, convivialità, condivisione, cultura, economia giusta, felicità, allora deve tornare al centro delle vite di tutti, anche di chi oggi non ne ha e deve essere liberato dalla sua condizione di mancanza.
Oggi nel mondo non c’è soltanto chi ha poco, ma comunque abbastanza: ci sono quelli, troppi, che non hanno a sufficienza o non hanno nulla da mangiare.
Oggi si tollera la fame come una sventura capitata a qualcuno, lontano. La si considera come una catastrofe naturale, come un elemento ineluttabile che colpisce alcuni sfortunati, senza motivo e senza colpa, ma senza redenzione. Non è così, non può essere così in un mondo evoluto come il nostro.
Chi lavora la terra, chi fa il pescatore, chi sa rapportarsi con la natura per procurarsi nutrimento in maniera rispettosa è una persona da conoscere e da ascoltare.
Quando ci accusano di essere utopisti, dobbiamo saper rispondere che c’è molta più concretezza nell’utopia che nel falso pragmatismo di tanta economia che ci contrabbandano come unica legge imperante.
Ormai i programmi politici, davanti al potere del mercato, contano zero. Perché se tu accetti la logica del mercato puoi fare il programma politico più progressista del mondo ma poi non lo riesci ad attuare.
Attraverso il cibo si può fare tutto, si può fare politica, economia, sociologia.
La grande gastronomia nasce nelle case contadine, nell’economia rurale che non aveva niente ma riusciva a creare piatti straordinari.
Le nonne sono state le prime e le più importanti educatrici alimentari. Pozzi di sapienza gastronomica che allenavano quotidianamente il gusto dei nipotini.
La felicità per me ha a che fare con la scienza gastronomica, che è la sua disciplina. Ha a che fare con la conoscenza del cibo e con un buon rapporto con esso.
Erano le nonne che ti aiutavano a superare la diffidenza verso la pellicina del pomodoro, l’amaro di certe verdure, il molle di certe zuppe, la pellicola del latte bollito. Sono state le prime esperienze nella cucina delle nonne a formare generazioni di persone, da che mondo è mondo.
Non siamo nessuno, e non siamo felici, se siamo chiusi, se siamo soli.
La diversità è la forza creativa più potente del mondo; grazie a essa si cresce e si cambia, ci si adatta, si migliora. Ce lo insegna la natura con i suoi meccanismi ma ce lo insegna anche la cultura, come quella alimentare.
Il cibo è una delle forme più alte e immediate della nostra espressione culturale: alta perché è frutto dell’ingegno, della creatività, della fatica, del sapere; immediata perché si mangia, diventa subito parte di noi stessi, si può provare senza filtri e, molto importante, ci lega sempre con un filo diretto alla natura, di cui siamo parte semplicemente in quanto viventi.
C’è cultura (tanta!) nell’agricoltura e nel modo di farla, nelle ricette tramandate o inventate, nella manualità, nel saper fare che sta dietro a tutti i processi che portano il cibo «dal campo alla tavola».
Siamo piccoli di fronte alla natura e per questo il nostro atteggiamento dovrebbe essere fatto di un’umiltà che ci conduca a una proficua interazione.
Siamo natura, siamo cibo, siamo energia, siamo umani. E il denaro non è niente di tutto questo.
C’è bisogno di poesia? Sì, ce n’è un dannato bisogno. Anche perché la poesia è uno strumento di felicità portentoso: permette di trovarla nei luoghi più impensabili, nelle cose e nelle azioni apparentemente più insignificanti.
Un po’ di utopia, e di poesia, forse fa bene alla salute e alla società.
Bisogna riaffermare l’orgoglio di una politica che si nutre di poesia e utopia. E che è uno strumento di servizio, perché anche di questo ci si sta dimenticando.
Terrafutura
Dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale © Giunti e Slow Food Editore, 2020
La mia vita ha sempre ruotato intorno al cibo. All’inizio per puro piacere, poi per passione e lavoro e infine per convincimento politico.
Il cibo è un universo pressoché infinito di connessioni, rimandi, concatenazioni e influenze tra ambiti completamente diversi, che richiede un approfondimento continuo anche se non potrà mai essere compreso fino in fondo.
Ascolto e generosità, confronto e intelligenza affettiva, dialogo e reciprocità devono essere considerati elementi centrali di un nuovo sistema economico, non capricci da anime belle.
Note