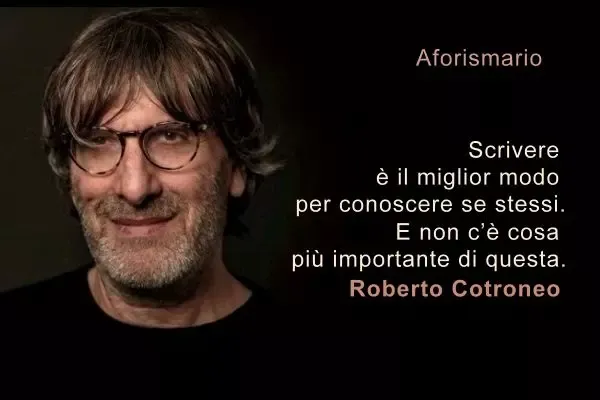Raccolta di frasi filosofiche incomprensibili e di riflessioni metafisiche astruse o, nel migliore dei casi, molto complesse e difficili da comprendere. Se c'è una cosa che più di ogni altra si rimprovera a certi filosofi è proprio il fatto di parlare di cose troppo astratte, di esprimersi in modo troppo complicato e di non farsi capire se non da chi condivide lo stesso gergo filosofico.
Come nota Karl Popper:
"Ogni filosofia, e in particolare ogni "scuola" filosofica, è soggetta a una degenerazione tale che i suoi problemi diventano praticamente indistinguibili da pseudo-problemi, e il suo gergo, in conseguenza, non può più essere distinto in pratica dal chiacchierio privo di significato". [Congetture e confutazioni, 1963].
Come nota Giovanni Soriano:
"Chiunque scriva in maniera oscura e sofisticata, rendendo complesse anche le cose più semplici e incomprensibili quelle più banali, obbligando il lettore a uno sforzo di concentrazione per capire che quanto si è letto non valeva la pena di essere né letto né scritto, è un miserabile impostore, fosse pure il più acclamato dei filosofi. [...] 'La chiarezza è la cortesia del filosofo', dice José Ortega y Gasset. No, non si tratta di cortesia, si tratta di semplice onestà intellettuale". [L'inconveniente umano, 2022].
Tra i filosofi più incomprensibili che Aforismario ha individuato fino a oggi vi sono: Hegel, Husserl e Heidegger, di cui si riportano varie citazioni. Un consiglio: dopo aver letto i seguenti passi filosofici, conviene fare una passeggiata all'aria aperta, magari in un parco, per ridiscendere coi piedi per terra e riprendere contatto con la realtà.
 |
| Soltanto nella filosofia la ragione è del tutto presso sé stessa. (Hegel) |
L’autocoscienza è la riflessione a partire dall’essere del mondo sensibile e percepito, ed è essenzialmente il ritorno dall’essere-altro. In quanto autocoscienza, essa è movimento; ma poiché essa distingue da sé soltanto se stessa in quanto se stessa, allora ai suoi occhi è immediatamente levata la differenza, intesa come un essere-altro. La differenza dunque non è, e l’autocoscienza è solamente l’immota tautologia dell’“Io sono Io”; nella misura in cui agli occhi dell’autocoscienza la differenza non ha anche la figura dell’essere, l’autocoscienza non è tale.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito, 1807
Solo nell’autocoscienza intesa come concetto dello spirito la coscienza ha il proprio punto di svolta: laddove essa, abbandonando la colorata parvenza dell’aldiqua sensibile, e la vuota notte dell’aldilà soprasensibile, fa il suo ingresso nel giorno spirituale della presenza.
G. W. F. Hegel, ibidem
L’autocoscienza è, innanzitutto, semplice essere-per-sé, è uguale a se stessa, escludendo da sé tutto quel che è altro; l’Io costituisce ai suoi occhi la sua essenza e il suo oggetto assoluto; ed in questa immediatezza, o in questo essere del suo essere-per-sé, l’autocoscienza è un che di singolo.
G. W. F. Hegel, ibidem
L’essenza dell’autocoscienza autonoma è, da una parte, solamente la pura astrazione dell’Io; dall’altra, mentre tale astrazione si viene formando e si dà differenze, agli occhi di quell’autocoscienza tale differenziare non diviene essenza oggettiva in-sé-essente.
G. W. F. Hegel, ibidem
Pensare vuol dire essere oggetto a se stesso non come Io astratto, bensí come Io che ha nel contempo il significato di essere-in-sé; ovvero, vuol dire rapportarsi all’essenza oggettiva in modo tale che essa abbia il significato di essere-per-sé della coscienza per la quale tale essenza è.
G. W. F. Hegel, ibidem
Per la coscienza infelice, l’essere-in-sé costituisce l’aldilà di se stessa. Ma il compiersi del suo movimento, in lei, ha fatto sí che la singolarità venisse posta nel suo completo sviluppo; ossia ha posto quella singolarità in cui consiste la coscienza effettiva come il negativo della coscienza stessa, cioè come l’estremo oggettivo; ovvero ancora, la coscienza ha lottato per estrapolare da sé il proprio essere-per-sé, e ne ha fatto l’essere.
G. W. F. Hegel, ibidem
Ciò che è universalmente valido esercita anche universalmente la propria validità; ciò che deve essere, è anche di fatto, e ciò che si limita a dover essere, senza però essere, non ha verità alcuna.
G. W. F. Hegel, ibidem
Il fare dell’autocoscienza è un fare del desiderio soltanto secondo uno dei momenti: essa non procede a cancellare l’intera essenza oggettiva, bensí solamente la forma del suo essere-altro o della sua autonomia, che è una parvenza priva d’essenza; infatti essa considera quell’essere-altro, in sé, come l’essenza stessa, ossia alla stregua della propria ipseità.
G. W. F. Hegel, ibidem
Quando la certezza di essere ogni realtà è elevata a verità, la ragione è spirito, ed è consapevole di se stessa come del proprio mondo, e del mondo come di se stessa.
G. W. F. Hegel, ibidem
Lo spirito è il Sé della coscienza effettiva, a cui esso viene a contrapporsi; o piuttosto, è quella coscienza che viene a contrapporsi a se stessa come mondo oggettivo ed effettivo; un mondo che però ha perduto per il Sé ogni significato d’estraneità, cosí come il Sé ha perduto ogni significato di essere-per-sé separato, dipendente o indipendente dal mondo.
G. W. F. Hegel, ibidem
Lo spirito è l’essenza reale assoluta che sostiene se stessa.
G. W. F. Hegel, ibidem
Lo spirito di questo mondo è l’essenza spirituale compenetrata da un’autocoscienza che si sa immediatamente presente come questa autocoscienza essente per sé, e che sa l’essenza come una realtà effettiva di fronte a sé.
G. W. F. Hegel, ibidem
Lo spirito che sa lo spirito è coscienza di se stesso, ed è ai propri occhi nella forma dell’oggettività: esso è; e nel contempo è l’essere-per-sé. È per sé, è il lato dell’autocoscienza, e lo è appunto di contro al lato della sua coscienza, ossia del rapportarsi a se stesso come oggetto.
G. W. F. Hegel, ibidem
Nulla viene saputo che non sia nell’esperienza, ossia – secondo un altro modo di esprimere la medesima cosa – non viene saputo nulla che non sia dato come verità avvertita dai sensi, come eterno rivelato interiormente, come sacro a cui si crede, o come altrimenti ci si voglia esprimere
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito, 1807
Il giudicare è un intendere (Meinen) e in generale un pretendere (Vermeinen) che la cosa stia cosi e cosi; il giudizio (ciò che è giudicato) è quindi solo qualcosa di preteso o meglio è il preteso contesto oggettivo oppure l’intenzione oggettiva, l’intenzione del contesto oggettivo. Ma di contro a ciò può sussistere una intenzione giudicativa privilegiata, cioè l'aver-consaputo giudicativamente una cosa determinata. Ciò dicesi evidenza.
Edmund Husserl, Meditazioni cartesiane, 1950
Tutte le teorie filosofico-trascendentali della conoscenza che compongono la critica della conoscenza ci conducono in fine alla critica originaria della conoscenza fenomenologico-trascendentale (innanzitutto dell’esperienza trascendentale); a sua volta questa critica, nell’atto in cui la fenomenologia si riporta essenzialmente a se stessa, avrà bisogno di una nuova critica.
Edmund Husserl, ibidem
L’ego trascendentale è risultato dalla messa in parentesi dell’intero mondo oggettivo e di tutte le altre oggettività (anche ideali). Mediante quest’atto io son divenuto conscio di me come ego trascendentale, che nel suo vivere costitutivo costituisce tutto ciò che mi è oggettivo; l’io di tutte le costituzioni, il quale sta nei suoi vissuti attuali o potenziali e nelle sue abitualità d’io e in queste spiritualità e in questi momenti costituisce anche, come ogni che di oggettivo, cosi anche se stesso in quanto ego identico.
Edmund Husserl, ibidem
Nell’esperienza dell’altro, così com’esso mi si dà direttamente quando io ne approfondisco il contenuto ontico-noematico (puramente come correlato del mio cogito, la cui struttura particolare dev’essere ancora mostrata), io non ottengo che una guida trascendentale.
Edmund Husserl, ibidem
Quando io nella riduzione trascendentale rifletto su di me, come ego trascendentale, io sono dato per me come questo ego nella maniera della percezione, anzi in percezione comprensiva. Io divengo consapevole anche di ciò, che io per l’innanzi c’ero già come dato per me, ma senza essermi colto, in modo originariamente intuitivo (in senso più ampio, percepito).
Edmund Husserl, ibidem
Manifestamente, la sfera di proprietà, essenziale a me come ego, non si estende soltanto — e questo è degno di particolare attenzione — alle attualità o potenzialità del corso dei vissuti ma, come ai sistemi costitutivi, cosi anche alle unità costituite, questo però solo entro certi limiti. Cioè, se ed in quanto l’unità costituita è inseparabile dalla costituzione originale stessa, nel modo d’una unicità concreta immediata, in tanto l’essere percepito, come il percepire costitutivo, appartiene alla mia proprietà concreta.
Edmund Husserl, ibidem
Quando nell’esperienza si rileva un oggetto concreto come qualcosa a sé e quando vi si dirige l’attenzione dello sguardo comprensivo, allora, in tale prensione semplice, esso ci si appropria come mero oggetto indeterminato della intuizione empirica. Determinato e ulteriormente determinantesi, esso lo diviene quando l’esperienza prosegue sotto forma di un’esperienza determinante ed anzi descrittiva dell’oggetto stesso in base ad esso, ossia sotto forma di una pura esplicitazione. Questa esperienza, pro-cedendo in sintesi articolate sul fondamento dell’oggetto dato in identità con se stesso nella sintesi intuitiva continuata della identificazione, sviluppa, in legami di intuizioni particolari, le determinazioni proprie dell’oggetto stesso, ossia le determinazioni interne. Queste compaiono originariamente come tali che in esse l’oggetto identico, stesso, per ciò che esso è, anzi per ciò che è in sé e per sé, è in se stesso, e vi si esplica nelle proprietà particolari il suo essere identico, ossia ciò che esso - in particolare - è.
Edmund Husserl, Meditazioni cartesiane, 1950
L’ente che ci siamo proposti di esaminare è il medesimo che noi stessi sempre siamo. L’essere di questo ente è sempre mio. Nell’essere che è proprio di esso, questo ente stesso si rapporta al proprio essere. Come ente di questo essere, esso è rimesso al suo aver-da-essere. L’essere è ciò di cui ne va sempre per questo ente.
Martin Heidegger, Essere e tempo, 1927
L’essenza dell’Esserci consiste nella sua esistenza. I caratteri evidenziabili di questo ente non sono quindi «proprietà» semplicemente-presenti di un ente semplicemente-presente, «avente l’aspetto» di essere così o così, ma sono sempre e soltanto possibili maniere di essere dell’Esserci, e null’altro. Ogni esser-così, proprio di questo ente, è primariamente essere. Perciò il termine «Esserci», con cui indichiamo tale ente, esprime l’essere e non il che-cosa, come quando si dice pane, casa, albero.
Martin Heidegger, ibidem
L’Esserci si determina come ente sempre a partire da una possibilità che egli stesso è e che, nel suo essere, in qualche modo comprende. Questo è il senso formale della costituzione dell’esistenza dell’Esserci.
Martin Heidegger, ibidem
L’Esserci è un ente che, comprendendosi nel suo essere, si rapporta a questo essere. Con ciò è indicato il concetto formale di esistenza. L’Esserci è inoltre l’ente che io stesso sempre sono. L’esser-sempre-mio appartiene all’Esserci esistente come condizione della possibilità dell’autenticità e dell’inautenticità. L’Esserci esiste sempre in uno di questi modi o nell’indifferenza modale rispetto a essi.
Martin Heidegger, ibidem
Quando indaghiamo ontologicamente il «mondo», non abbandoniamo per nulla il campo tematico dell’analitica dell’Esserci. Ontologicamente il «mondo» non è affatto una determinazione dell’ente difforme dall’Esserci, ma è, al contrario, un carattere dell’Esserci stesso. Ciò non esclude però che la via della ricerca intorno al fenomeno del «mondo» debba passare attraverso l’ente intramondano e il suo essere.
Martin Heidegger, ibidem
Il mondo non è esso stesso un ente intramondano; tuttavia esso determina questo ente in modo tale da far sì che possa essere incontrato e manifestarsi nel suo essere, come ente scoperto, solo perché «c’è» il mondo.
Martin Heidegger, ibidem
L’essere-nel-mondo, cui appartiene con uguale originarietà l’essere-presso l’utilizzabile e il con-essere con gli altri, è sempre in-vista-di se stesso. Il se-Stesso è però, innanzi tutto e per lo più, un se-stesso inautentico, un Si-stesso. L’essere-nel-mondo è sempre già deietto. La quotidianità media dell’Esserci può quindi essere determinata come l’essere-nel-mondo deiettivo-aperto e gettato-progettante, per il quale, nel suo esser-presso il «mondo» e nel con-essere con gli altri, ne va del suo stesso poter-essere più proprio.
Martin Heidegger, ibidem
La distinzione così evidente dell’essere dell’Esserci esistente rispetto all’essere dell’ente non conforme all’Esserci (ad esempio la realtà) è solo il punto di partenza della problematica ontologica e non qualcosa in cui la filosofia possa acquietarsi.
Martin Heidegger, Essere e tempo, 1927
L’uomo, che è un ente fra gli altri, «fa scienza». In questo «fare» accade niente di meno che l’irruzione di un ente, detto uomo, nella totalità dell’ente, in modo tale che l’ente, in questa e per questa irruzione, si dischiude in ciò che è e per come è. È solo questa irruzione che dischiude a consentire a suo modo all’ente di arrivare a se stesso.
Martin Heidegger, Che cos’è metafisica?, 1929
La scienza rifiuta il Niente e lo abbandona come nullità. Ma abbandonando il Niente in questo modo, non finiamo forse proprio per ammetterlo? E, d’altra parte, possiamo parlare di un’ammissione se ciò che ammettiamo è niente? Ma forse con questo «andirivieni» del discorso ci muoviamo in un vuoto gioco di parole.
Martin Heidegger, ibidem
Che cosa può essere per la scienza il Niente se non una mostruosità e una fantasticheria? Se la scienza ha ragione, allora una cosa è certa: del Niente la scienza non vuol saperne niente. Questa è dunque la comprensione scientificamente rigorosa del Niente. Del Niente sappiamo che non vogliamo saperne niente.
Martin Heidegger, ibidem
Solo sul fondamento dell’originaria manifestatezza del Niente, l’esserci dell’uomo può dirigersi all’ente e occuparsene. Ma in quanto l’esserci per sua essenza si rapporta all’ente, all’ente che egli non è e all’ente che egli stesso è, l’esserci, in quanto esserci, già da sempre proviene dal Niente che è manifesto.
Martin Heidegger, Che cos’è metafisica?, 1929
Esser-ci significa essere tenuto immerso nel Niente. Tenendosi immerso nel Niente, l’esserci è già sempre oltre l’ente nella sua totalità. Questo essere oltre l’ente noi lo chiamiamo trascendenza. Se l’esserci, nel fondo della sua essenza, non trascendesse, ossia, come ora possiamo dire, non si tenesse immerso fin dall’inizio nel Niente, non potrebbe mai rapportarsi all’ente, e perciò neanche a se stesso.
Martin Heidegger, ibidem
Il Niente non è un oggetto, né in generale un ente. Il Niente non si presenta per sé, né accanto all’ente a cui per così dire inerisce. Il Niente è ciò che rende possibile la manifestatezza dell’ente come tale per l’esserci umano. Il Niente non dà solo il concetto opposto a quello di ente, ma appartiene originariamente all’essere essenziale (Wesen) stesso. Nell’essere dell’ente avviene il nientificare del Niente.
Martin Heidegger, ibidem
L’esserci umano può comportarsi in rapporto all’ente solo se si tiene immerso nel Niente. L’andare oltre l’ente accade nell’essenza dell’esserci. Ma questo andare oltre è la metafisica stessa. Ciò implica che la metafisica faccia parte della «natura dell’uomo».
Martin Heidegger, Che cos’è metafisica?, 1929
Se la filosofia comincia con la creazione dei concetti, il piano di immanenza deve essere considerato pre-filosofico. Ne è presupposto, non alla stregua di un concetto che rinvierebbe ad altri, ma nel senso di una comprensione non concettuale cui i concetti stessi rinviano. E questa comprensione intuitiva varia ancora a seconda del modo in cui il piano è tracciato.
Gilles Deleuze e Félix Guattari, Che cos’è la filosofia?, 1991
Note
Vedi anche aforismi, frasi e citazioni su: Filosofia - Filosofare - Filosofi - Sistemi Filosofici - Metafisica